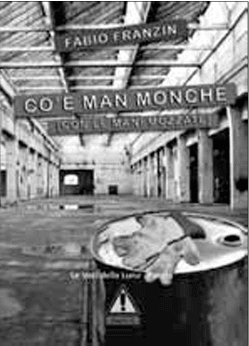|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saggi e testi online |
|
|
|
|
|
| Visits since 10 July '98 |
|
      
|
|
|
|
« indietro
FABIO FRANZIN, Co’ e man monche [Con le mani mozzate], Milano, Le voci della luna, 2011, pp. 93, €10,00.
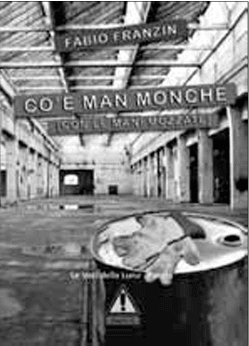
Il cronotopo – per servirci a bella posta di un noto tecnicismo letterario e così tenere a distanza la molta vicinanza alla realtà del libro – è quello del trevigiano sud-orientale negli anni di oggi, cioè quelli della crisi per globalizzazione («globaizazhión, maedhéta»), quando perfino il modello del nord-est va in pezzi: «passà el sant, passà el miràcoeo» (sono rimaste le bollette). Il disastro è sta to più volte tematizzato da artisti e scrittori che lo hanno rappresentato concentrandosi soprattutto sulla forza, negativa e poetica dei non-luoghi: la forza di senso paradossalmente generata dal trattamento ‘artistico’ (fotografie, descrizioni) di costruzioni oramai prive di senso (è tutto un: vendesi, fitasi), fabbriche, aree commerciali. Franzin si concentra invece sull’antropologia di quella crisi, parla degli effetti sugli operai (non esiste più la classe operaia?), colpiti (come i ‘padroni’ e naturalmente peggio di questi), non solo nel portafoglio ma, molto più crudelmente, nell’etica del lavoro. Persa quella si perde perfino il senso delle generazioni e quello dello stare al mondo («el lavoro sparìo / parfin ai pensieri, daa speranza»). Lavoro quindi esisto, catene di fedeltà familiari ed aziendali cancellate in pochissimo tempo, l’umiliazione di passare giornate infinite a casa o a vagare in paese come l’ultimo de «quei che no’à vòjia / de far nient». Se fosse un film di Ken Loach, la storia finirebbe magari male ma ci sarebbe un po’ di vecchio sano moralismo per cui quello che resta è una solidarietà tra i lavoratori, sconfitti ma non umiliati nella dignità. Qui assistiamo invece al disfarsi del gruppo degli operai «fradhèi ribandonàdi da un pare», dopo l’annuncio della chiusura: erano ottantatre sul piazzale, rimangono in due. L’uso del dialetto non si concede mai effetti di mimetismo linguistico (tranne che in una delle Prose del tricolore, che si immagina scritta da un camionista ‘degradato’ a operaio, in una specie di italiano di continuo sprofondante nel dialetto). Il dialetto compone piuttosto una sorta di recitativo: il nastro che si srotola a vuoto trascinando i pensieri neri dell’inanità di quelle mani private di lavoro. Si può anzi dire che, letterariamente, la forza del libro sta tutta in questa rinuncia a incidere per via espressionista sul reale. È il reale invece che si fa corpo della crisi e trova spazio per entrare dentro con la forza sottile di una malattia psicosomatica, come l’eczema che compare sulle mani dopo qualche mese di cassa integrazione, la pelle che si squama, rossa: «El dermatòego dise l’é un sfogo / nervoso, ‘na risposta del só corpo / al stress […] ‘tanti stanno vivendo la sua / stessa situazione’. Lù sa che ‘e só / man ‘e se ‘à maeà parché inciodàdhe / tel nient. Nissùna pomata le guarirà» (‘Lui sa che le sue / mani si sono ammalate perché inchiodate nel vuoto. Nessun unguento le guarirà’). È la poesia di Franzin che è poesia psicosomatica: tra la causa vera e il sintomo, è l’antropologia di quest’ultimo, ed è una lingua che niente potrà guarire.
(Fabio Zinelli)
¬ top of page
|
|
| Iniziative |
|
|
11 gennaio 2026
Addio a Giancarlo Cauteruccio
11 dicembre 2025
Convegno Compalit, Pisa 11-13/12/25: Filtri. La forma come mediazione e come conflitto
5 dicembre 2025
Semicerchio a "Più libri più liberi" (Roma)
3 dicembre 2025
Dialogo con Jorie Graham-Torino
12 ottobre 2025
Semicerchio al Salon de la Revue di Parigi
9 ottobre 2025
Addio a Francesco Recami
26 settembre 2025
Semicerchio a Bright -Siena
22 settembre 2025
Adesione sciopero per Gaza
21 settembre 2025
Semicerchio col CRIC a Firenze RiVista
9 settembre 2025
In memoria di Anna Maria Volpini - Firenze, 9 settembre
1 settembre 2025
Per i 90 anni di Charles Wright - di Antonella Francini
7 giugno 2025
Semicerchio per Gaza
26 marzo 2025
Semicerchio a UNISTRASI
5 marzo 2025
Il testo-natura. Presentazione di Semicerchio 70 e 71, Roma Sapienza.
22 novembre 2024
Recensibili per marzo 2025
19 settembre 2024
Il saluto del Direttore Francesco Stella
19 settembre 2024
Biblioteca Lettere Firenze: Mostra copertine Semicerchio e letture primi 70 volumi
16 settembre 2024
Guida alla mostra delle copertine, rassegna stampa web, video 25 anni
21 aprile 2024
Addio ad Anna Maria Volpini
9 dicembre 2023
Semicerchio in dibattito a "Più libri più liberi"
15 ottobre 2023
Semicerchio al Salon de la Revue di Parigi
30 settembre 2023
Il saggio sulla Compagnia delle Poete presentato a Viareggio
11 settembre 2023
Recensibili 2023
11 settembre 2023
Presentazione di Semicerchio sulle traduzioni di Zanzotto
26 giugno 2023
Dante cinese e coreano, Dante spagnolo e francese, Dante disegnato
21 giugno 2023
Tandem. Dialoghi poetici a Bibliotecanova
6 maggio 2023
Blog sulla traduzione
9 gennaio 2023
Addio a Charles Simic
9 dicembre 2022
Semicerchio a "Più libri più liberi", Roma
15 ottobre 2022
Hodoeporica al Salon de la Revue di Parigi
13 maggio 2022
Carteggio Ripellino-Holan su Semicerchio. Roma 13 maggio
26 ottobre 2021
Nuovo premio ai traduttori di "Semicerchio"
16 ottobre 2021
Immaginare Dante. Università di Siena, 21 ottobre
11 ottobre 2021
La Divina Commedia nelle lingue orientali
8 ottobre 2021
Dante: riletture e traduzioni in lingua romanza. Firenze, Institut Français
21 settembre 2021
HODOEPORICA al Festival "Voci lontane Voci sorelle"
11 giugno 2021
Laboratorio Poesia in prosa
4 giugno 2021
Antologie europee di poesia giovane
28 maggio 2021
Le riviste in tempo di pandemia
28 maggio 2021
De Francesco: Laboratorio di traduzione da poesia barocca
21 maggio 2021
Jhumpa Lahiri intervistata da Antonella Francini
11 maggio 2021
Hodoeporica. Presentazione di "Semicerchio" 63 su Youtube
7 maggio 2021
Jorie Graham a dialogo con la sua traduttrice italiana
23 aprile 2021
La poesia di Franco Buffoni in spagnolo
22 marzo 2021
Scuola aperta di Semicerchio aprile-giugno 2021
19 giugno 2020
Poesia russa: incontro finale del Virtual Lab di Semicerchio
1 giugno 2020
Call for papers: Semicerchio 63 "Gli ospiti del caso"
30 aprile 2020
Laboratori digitali della Scuola Semicerchio
» Archivio
|
|
|
|
 |
|
»
»
»
»
»
»
»
»
»
|
|
|
|
|
|
|
|
| Editore |
|
|
|
|
| Distributore |
|
|
|
|
Semicerchio è pubblicata col patrocinio del Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali dell'Università di Siena viale Cittadini 33, 52100 Arezzo, tel. +39-0575.926314, fax +39-0575.926312
|
|
web design: Gianni Cicali

|
|
|
|