
« indietro
Odorico Mendes,
un traduttore brasiliano dei classici in chiave poetica [1]
di Paulo Sérgio de Vasconcellos
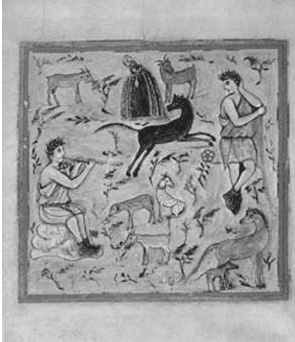
Vergilius Romanus (Vat. Lat. 3867 f. 44v)
Nel 1854 usciva a Parigi, ad opera del politico [2] e giornalista [3] brasiliano Manuel Odorico Mendes (1799-1864), una traduzione ell’Eneide intitolata Eneide Brasiliana (Eneida Brasileira), evocando provocatoriamente un’altra traduzione, quella del portoghese Franco Barreto, giustamente chiamata Eneide Portoghese (Eneida Portuguesa), del secolo XVII. Quattro anni dopo, Odorico Mendes nella stessa città pubblicò il Virgilio Brasiliano (Virgílio Brasileiro), traduzione di tutte le opere virgiliane in versi endecasillabi [4]; qui la versione dell’Eneide veniva rivista e modificata, e veniva aggiunto il testo latino che mancava nella prima edizione. Già nel volume del ’54, sulla prima pagina si leggeva «traduzione poetica», formula che riassumeva tutto un progetto di poetica della traduzione: una ricreazione poetica in altra lingua degli effetti poetici dell’originale e non una semplice parafrasi in prosa. Dopo una carriera politica molto attiva in Brasile, nel 1847 Odorico Mendes si trasferì in Francia, dove si dedicò totalmente al suo lavoro di traduzione dei classici. Come si legge nelle sue lettere piene di amarezza, trovava difficoltà, talvolta estreme, a sopravvivere ed educare i figli. Postume uscirono le pubblicazioni dell’Iliade (1867) [5] e dell’Odissea (1928) [6], un lavoro faticoso che debilitò la salute del tradutore. Per avere accesso ai materiali necessari al compimento della traduzione di Omero, Odorico si recò a Pisa, dove rimase per circa due anni (dal 1861 al 1863) prima di ritornare a Parigi [7]. Dopo molti anni di soggiorno europeo, nel 1864 morì a Londra, dove si era recato per un’ultima visita alla città prima di ritornare in Brasile [8] .
La fortuna del traduttore è stata piuttosto controversa: se la critica fu divisa riguardo alle traduzioni di Virgilio fin dalla pubblicazione dell’Eneide e di tutto Virgilio (ma non mancarono gli ammiratori, anche entusiastici), fu prevalentemente negativa per quanto riguarda il suo Omero – talvolta ferocemente negativa [9] – attraverso gli anni fino a che Odorico non ebbe il suo riscatto clamoroso. Questa rivalutazione ebbe luogo prima grazie alla voce autorevole di pochi critici, come il poeta brasiliano e teorico della traduzione Haroldo de Campos, dopo in tutta una serie di pubblicazioni fatte in modo accurato, corredate di note e commenti, necessari a causa della difficoltà di molti passi dei testi. In Brasile oggi si può dire che si è fatta giustizia al progetto di Odorico e non si sentono più critiche forti o ingenue: le traduzioni vengono apprezzate come un progetto originale, innovativo in un’area di studio, le lettere classiche, talvolta troppo conservatrice per accettare una traduzione lontana da qualsiasi pretesa di fedeltà stretta alla lettera del testo che ne sacrifichi la poeticità.
Oltre agli effetti di suono, ritmo, ordine delle parole, va considerata la poeticità dei significati, cioè un modo di esprimerli che li allontana dal linguaggio comune creando una «stranezza» che viene percepita come linguaggio marcato. Una caratteristica delle traduzioni di Odorico che le contradistinguono da altre traduzioni dei classici in lingua portoghese è la ricreazione del senso degli originali in modo che la sua singolarità riceva un equivalente che provocherà la stessa «stranezza» o senso della non-banalità in portoghese. Un piccolo esempio: nel primo libro dell’Eneide, l’espressione oscula libauit natae (v. 256) è tradotta «da filha ósculos liba» (v. 275): al lettore il compito di interpretare cosa significa «libar ósculos» (cfr. il lemma libo dell’Enciclopedia Virgiliana, III, p. 207). Invece la maggior parte dei traduttori parafrasa il testo, spiegandolo e banalizzandolo. Sarebbe facile moltiplicare gli esempi di questo aspetto delle traduzioni di Odorico Mendes.
Certo la definizione del discorso poetico è una questione complessa; si sarebbe portati a credere che nell’Antichità un discorso poetico si contraddistinguesse per la sua metrica regolare, ma basta ricordare Aristotele per renderci conto di come sia difficile precisare la natura della poesia in opposizione alla prosa: per il filosofo, infatti, Empedocle, nonostante si fosse espresso in versi, non dovrebbe essere considerato un poeta (Poetica 1447 a) [10]. Dall’Orator (XX, 66) si ricava che gli antichi discutevano sulla differenza fra il poeta e l’oratore e una risposta frequente era che essa consisteva soprattutto nel ritmo e nel verso della poesia (numero maxime uidebantur ante et uersu), ma l’esistenza anche di un ritmo oratorio complicava le cose. Inoltre l’elocuzione di Platone e Democrito, che pure non utilizza dei versi, ad alcuni sembrava più prossima a un poema rispetto alle opere dei poeti comici, che a parte i versi hanno un linguaggio del tutto simile al sermo cotidianus (67) [11]. Per Quintiliano, Cornelio Severo è migliore verseggiatore che poeta (Cornelius autem Seuerus, etiam si est uersificator quam poeta melior... Inst. Or., X, 1, 89) e Lucano deve essere imitato più da oratori che da poeti (magis oratoribus quam poetis imitandus, I, 1, 90). Lo stesso Quintiliano in un celebre brano afferma che la historia è molto vicina alla poesia (proxima poetis, X, 1, 31). Insomma, una lunga discussione che è arrivata ai nostri giorni e che abbiamo appena segnalata qui.
Uno degli aspetti interessanti delle traduzioni di Odorico è il suo carattere intertestuale: non solo il traduttore incorpora soluzioni di altri (anche da traduzioni italiane o francesi) che gli sembrano esemplari, ma riproduce espressioni o versi di altri poeti, soprattutto di Camões. Se il Lusitano programmaticamente inizia la sua epopea sulle navigazioni portoghesi traducendo con leggera modifica la proposizione virgiliana (As armas e os barões; cfr. Arma uirumque), Odorico accoglie versi ed espressioni camoniani soprattutto quando il poeta portoghese imita da vicino un brano virgiliano che Odorico sta traducendo. Ad esempio, nel libro VII, v. 676, nel testo di Virgilio compare l’ablativo assoluto instructo Marte. Odorico traduce «[em] Marte instructo», un sintagma che produce stra- nezza, ma che il lettore di Camões riconosce, giacchè nella sua epopea si legge «com Marte instruto» (Os Lusíadas, II, 453, 1). Camões traduce letteralmente Virgilio, e Odorico riproduce questa traduzione camoniana dello stesso brano. Traduttori portoghesi avevano già operato così e Odorico li imita, talvolta indicandolo nei suoi commenti alle traduzioni, come per esempio:
‘Ao verso 518 adaptei um de Camões, e assim faço algumas
[vezes.’ [12]
(‘Nel verso 518 ho adattato uno di Camões, e così faccio alcune
[volte.’)
[vezes.’ [12]
(‘Nel verso 518 ho adattato uno di Camões, e così faccio alcune
[volte.’)
Infine per il lessico Odorico ricorre spesso a Camões, soprattutto quando si tratta di latinismi che conferiscano alla traduzione un tono arcaizzante. [13] Traducendo il latino, il portoghese si latinizza, spesso attraverso Camões.
Ma in cosa consiste l’audacia delle traduzioni di Odorico? Perché esse erano bersaglio facile per molti critici? Certo la scarsa tradizione classica in Brasile fu un grosso impedimento per la formulazione di un giudizio più sereno: ai lettori privi di latino o greco risultava impossibile osservare che nelle traduzioni c’era una ricerca quasi ossessiva della ‘fedeltà’ non al senso primo dei testi ma ai loro effetti poetici: al ritmo, al suono [14], all’ordine espressivo delle parole che il traduttore acopriva negli originali e cercava di riprodurre nella sua lingua, ricreando la ‘poeticità’ del latino virgiliano o del greco omerico in portoghese del Brasile. C’è poi l’immensa ricchezza lessicale e sintattica di quel Brasiliano che stando al poeta romantico Gonçalves Dias, padroneggiava il portoghese come nessun altro riusciva a fare al suo tempo [15]. Basti pensare che i dizionari moderni di lingua portoghese non sono sufficienti per capire tutto Odorico: per certe parole occorre consultare dizionari più antichi e più pieni di lemmi o sensi riscontrabili in classici della lingua portoghese poco letti oggi. Per quanto riguarda la sintassi, le brusche inversioni nell’ordine delle parole esigono lettori pronti ad impegnarsi per capire il disegno delle frasi. Per i classicisti il lavoro diventa molto più facile, perchè si accorgono che la sintassi tortuosa in certi brani imita quella dell’originale. Odorico cerca di ‘latinizzare’ o ‘ellenizzare’ il portoghese, cioè di fare sì che il portoghese subisca una forte influenza dalla lingua originale dei testi che traduce. Per fare un esempio, nella sua traduzione dal greco, Odorico moltiplica i composti poetici, creati da lui [16] o presi a prestito da classici portoghesi: «flutissonante» (‘dai flutti che risuonano’), «dulcíloquo» (‘dalle parole dolci’), «arcitenente» (‘che tiene l’arco’), «albinitente» (‘dal bianco brillante’), ecc. [17] In questo modo il portoghese viene arricchito dall’influsso delle lingue tradotte e ciò porta al risultato indicato da Ortega y Gasset come l’obiettivo ideale della traduzione: «Il punto decisivo rimane quello di cercare nel tradurre di allontanarci dalla nostra lingua per andare verso le altre e non l’inverso, come di solito si fa». [18]
Haroldo de Campos, capostipite del cosiddetto movimento della poesia concreta e uno dei maggiori teorici della traduzione in Brasile, proponeva, in alternativa alla spesso sostenuta «tesi dell’impossibilità di principio della traduzione dei testi creativi» (p. 34), la tesi del lavoro traduttorio come lavoro creativo. [19] Non a caso il critico considerava Odorico Mendes un pioniere in Brasile della traduzione creativa, che invece di soggiogarsi a un ideale ingenuo di fedeltà al senso letterale, si assume il compito di ‘ricreare’ i testi originali. «Così testo di partenza e testo di arrivo, diversi quanto al linguaggio, saranno in una relazione di omologia di sistema» (p. 34); insomma, «la tra- duzione dei testi creativi sarà sempre ricreazione» (p. 35). Se il discorso è valido per qualsiasi testo di natura letteraria, vale ancor più per i testi poetici, in cui il linguaggio è messo in rilievo al punto da lasciarci dubbi sulla possibilità di trasferirlo ad un’altra lingua.
Spesso nelle prefazioni alla traduzione dei classici troviamo il discorso della fedeltà all’originale senza che questa ‘fedeltà’ sia messa in discussione, problematizzata. Cosa significa essere fedele a un testo in cui il lato più concreto del linguaggio (il suono, il ritmo, l’ordine delle parole) è così appariscente? [20] A Odorico non piacevano affatto – è lui stesso a dichiararlo – le parafrasi dei testi poetici che si presentavano come traduzioni. Essendo poeta lui stesso e sottile lettore di poesia, voleva vedere del poetico nelle traduzioni dei suoi classici più amati. Da parte nostra, non critichiamo le edizioni di testi classici che ci propongono una traduzione senza pretese poetiche, fedele al senso letterale e accompagnata di note e commenti. Anzì, queste edizioni e traduzioni, tipiche dei filologi, sono imprescindibili, hanno il loro ruolo e la loro destinazione. Ma che questi testi letterari, che hanno influenzato non a caso molti dei maggiori poeti dell’Occidente, non ricevano delle traduzioni più impegnate dal punto di vista della poeticità sarebbe frustrante. E succede spesso che i filologi – nel loro uso legittimo dei testi – non si accorgono degli aspetti più propriamente poetici, che verrebbero discussi e utilizzati anche in lavori di natura filologica. Ma questo è un altro discorso che ci porterebbe lontano.
La poesia è intraducibile? Nel sottotitolo stesso della sua traduzione dell’Eneide, Odorico Mendes dimostra la sua posizione: «traduzione poetica». E non si tratta soltanto di adottare una forma metrica rigida quale l’endecasillabo ma di ricreare in portoghese effetti poetici degli originali. Tuttavia, come riprodurre in un’altra lingua aspetti del latino o del greco che ci sembrerebbero appunto non traducibili? Come sfidò Odorico questa pretesa intraducibilità? Cominciamo con alcuni esempi [21] dell’aspetto che può sorprendere di più: la riproduzione, o meglio, la ricerca di un omologo del ritmo quantitativo. La lingua portoghese, naturalmente, non ha un ritmo quantitativo.
Si sa che i poeti antichi giocano con gli effetti prosodici delle quantità brevi e lunghe delle sillabe. Una successione di lunghe può dare l’impressione di un ritmo solenne o lento, e una sucessione di brevi trasmette il senso della velocità [22]. Ma come riprodurre queste sequenze di sillabe in una lingua di ritmo non quantitativo? Qualche esempio ci porterà nell’officina del traduttore che non si ritrae certo davanti alle difficoltà. Uno dei passi descrittivi magistrali dell’Eneide si trova nel secondo libro, quando Virgilio menziona il cadere su Troia di quella che sarebbe la sua ultima, tragica notte. In quei momenti che precedono l’irruzione sanguinosa dei greci, il poeta rappresenta le tenebre che sembrano coprire tutto il mondo:
Vertitur interea caelum et ruit Oceano nox
īnuōluēns ūmbrā māgnā tērramque polumque (vv. 250-251) [23]
Abbiamo segnalato i quattro piedi spondaici del verso 251: un ritmo regolare, pausato, che suggerisce il cadere delle ombre mentre poco a poco si abbattono sulla città, un effetto al quale contribuiscono i tre trisillabi (inuoluens, terramque, polumque). La traduzione di Odorico:
Vira o céu, no Oceano a noite cai,
E embuça em basta sombra a terra e o pólo
(‘Il cielo gira, nell’Oceano cade la notte
e involge in ombra fitta la terra e il polo’.)
Oltre a mantenere il monosillabo alla fine del verso 250, Odorico utilizza un ritmo assolutamente regolare in portoghese, una successione di piedi ‘giambici’, cioè una sequenza in cui ad una sillaba atona succede una tonica (queste segnalate infra in maiuscole):
(e)emBU/ç(a) em BAS/ta SOM/br(a) a TER/r(a) e o PÓ (l’ultima non viene considerata, come normale nella scansione dei versi endecasillabi nella tradizione lusobrasiliana).
Si noti l’alliterazione delle labiali: emBuça em Basta somBra e la forte presenza delle nasali: EMbuça EM basta sOMbra. Nel latino: INuoluENs UMbra MagNa. Infine, le sibilanti: embuÇa em baSta Sombra... Un verso che suona bellissimo e che ci offre un equivalente del ritmo spondaico di Virgilio: un ritmo di accento intensivo, ma con le sillabe disposte in modo regolare.
Un altro esempio, anch’esso dall’Eneide. Ecco un brano tratto dal celebre episodio della caccia del libro quarto:
pōstqu(am) āltōs uēnt(um) īn mōntīs ātq(ue)īnuia lūstra,
ecce ferae saxi deiectae uertice caprae
decurrere iugis (vv. 151-153)
Il verso 151 è pieno di lunghe; invece il secondo comincia con un dattilo saltellante; le tre parole che lo iniziano, tutte bisillabiche, sembrano contribuire al rimo agile e in contrasto con il ritmo precedente. La traduzione di Odorico cerca di mettere in rilievo la rapidità e crea un effetto di armonia imitativa:
Chega-se a alpestres montes e ínvias furnas,
Eis, de íngreme rochedo, despenhando-se,
Bravias cabras pelos picos pulam.
(‘Si è venuto a dei monti alpestri e recessi impraticabili.
Ecco dalla rocca ripida, lanciandosi giù,
Delle capre selvagge per i picchi saltano.’)
Chega-se a alpestres montes e ínvias furnas,
Eis, de íngreme rochedo, despenhando-se,
Bravias cabras pelos picos pulam.
(‘Si è venuto a dei monti alpestri e recessi impraticabili.
Ecco dalla rocca ripida, lanciandosi giù,
Delle capre selvagge per i picchi saltano.’)
Il «despenhando-se» alla fine del verso, con le sue cinque sillabe ritmiche, viene contrapposto alla successione di disillabi nel verso che segue; in questo secondo verso, abbiamo delle parole disillabiche (alla eccezione solo di «bravias») e tutte parossitone, cioè in ritmo ‘trocaico’:
bravias CAbras PElos PIcos PUlam
bravias CAbras PElos PIcos PUlam
Si noti la forte alliterazione della labiale sorda: «Pelos Picos Pulam». Si ha l’impressione di sentire il saltare degli animali. Notevole anche l’iconicità del gruppo «despenhando-se»: il pronome atono ‘se’allunga il polisillabo ad esso accoppiato, creando così un effetto curioso: la rappresentazione in chiave ritmicosintattica dell’idea di queste capre che sembrerebbero sospese dalle rocce come ‘sospesa’ dal verbo è la forma pronominale.
Insomma, Odorico Mendes percepisce che c’è un effetto ritmico nell’originale e lo ripropone in portoghese, anche facendolo più vistoso nella traduzione. Questo brano si impone come testo poetico indipendentemente dal fatto che sia una traduzione.
Un’altra caratteristica delle lingue antiche che producono degli enunziati apparentemente intraducibili è la possibilità– trattandosi di lingue flessive– di spostare con più grande libertà le parole della frase per ottenere maggiore espressività o iconicità. [24] Siccome il portoghese non è una lingua flessiva, sarebbe forse impossibile riprodurre certe frasi che giocano con l’allontanamento (talvolta molto accentuato) dei suoi membri? Una lettura attenta ci mostra che Odorico spesso percepisce nell’ordine delle parole degli originali un’espressività che tenta di non perdere nella traduzione.
Un esempio di «intraducibile» nella seconda bucolica: il pastore Coridone fa menzione del mazzo di fiori che una Naiade offrirebbe al giovane Alessi se questi si decidesse a venire in campagna:
tum casia atque aliis intexens suauibus herbis
mollia luteola pingit uaccinia calta. (II, vv. 49-50)
tum casia atque aliis intexens suauibus herbis
mollia luteola pingit uaccinia calta. (II, vv. 49-50)
Il verso 50 è aureus, giacché presenta due aggettivi seguiti da due sostantivi che quelli modificano (nel mezzo, il verbo):
mollia luteola pingit uaccinia calta.
a b A B
mollia luteola pingit uaccinia calta.
a b A B
L’ordine delle parole imita l’intrecciarsi dei fiori [25]: la calta, in mezzo ai giacinti, assortirà i colori del mazzo. Nella traduzione di Odorico:
E jalde, o ramalhete salpicando,
Moles jacintos lhe matiza a calta.
(‘E, gialla, cospargendo il mazzo,
con molli giacinti la calta lo dipinge’.)
E jalde, o ramalhete salpicando,
Moles jacintos lhe matiza a calta.
(‘E, gialla, cospargendo il mazzo,
con molli giacinti la calta lo dipinge’.)
Il sintagma «jalde calta» è stato separato nei suoi ele menti in modo da far sì che l’aggettivo venga quasi in prima posizione nel primo verso, mentre il sostantivo che esso modifica è espresso solo alla fine del verso seguente: jalde.../ calta. In questo modo, iconicamente, l’ordine delle parole imita l’oggetto riferito: la calta gialla avvolgente i delicati giacinti. Non è il medesimo effetto del testo virgiliano, ma è un effetto simile (l’imitazione di un disegno sintattico di natura iconica), ottenuto con economia di mezzi espressivi e un ordine di parole non usuale, come non usuale, anzi raffinatissimo, è quello di Virgilio.
Il classicista si renderà conto che spesso le traduzioni di Odorico non si attengono con rigidità alla lettera del testo [26], sebbene i sensi principali siano mantenuti con accuratezza. Ma dovrà anche accorgersi di quanto sia profonda la sua comprensione degli effetti poetici degli originali e di quale sistematico impegno egli metta nel ricrearli in portoghese. Leggere originale e traduzione penetrando nell’officina del traduttore per coglierlo al lavoro è un esercizio affascinante nel caso di questo pionere della traduzione poetica o (ri)creativa in Brasile che ha compiuto un lavoro inedito e mai uguagliato nel paese, la traduzione in versi di tutto Virgilio e di tutto Omero fatta da un singolo traduttore.
Paulo Sérgio de Vasconcellos
[UNICAMP–Università di Campinas, Brasile]
[UNICAMP–Università di Campinas, Brasile]
NOTE:
1. Ringrazio Silvia Ottaviano, che ha fatto una lettura attenta del mio testo, correggendo errori di italiano e proponendo delle modifiche per migliorarne lo stile e Andrea Cucchiarelli, che in un periodo di intensa attività ha trovato il tempo per leggere con la consueta perizia e generosità queste pagine, non senza propormi molti suggerimenti preziosi. Gli errori ancora rimanenti sono responsabilità dell’autore.
2. Odorico fu eletto deputato più di una volta ed ebbe un ruolo importante negli avvenimenti del primo e del secondo Impero in Brasile. Sappiamo che faceva arrivare all’Imperatore D. Pedro II qualche traduzione. Di recente sono stati ritrovati nel Palazzo Imperiale di Petrópolis, a Rio de Janeiro, i manoscritti (preceduti da un prologo inedito) della sua Iliade.
3. Sull’attività di Odorico come fondatore di periodici e articolista sempre combattivo e polemico, si possono leggere: Cardim, Elmano, Vidas gloriosas, Rio de Janeiro, 1971; Ignotus (Joaquim Serra), Sessenta anos de jornalismo. A imprensa no Maranhão. São Paulo, 2001. Manca però una biografia complessiva del personaggio.
4. Mendes, Odorico, Eneida Brazileira ou traducção poética da epopéa de Publio Virgilio Maro, Paris, Na Typograhia de Rignoux 1854; Virgilio Brazileiro ou traducção do poeta latino, Paris, Na Typographia de W. Remquet, 1858.
5. Iliada de Homero, Rio de Janeiro, Henrique Alves de Carvalho, 1874. Bisogna dire che Odorico Mendes fu il primo a tradurre integralmente Omero in lingua portoghese.
7. Una curiosità sui rapporti di Odorico con la Francia: Maurice Druon, lo scrittore francese morto di recente, discendeva da Odorico e nel bicentenario della nascita del traduttore andò in Brasile per le celebrazioni dell’evento.
8. In viaggio per nave da Lisbona, che intendeva fare in compagnia del suo amico e conterraneo Gonçalves Dias; ma anche l’amico poeta morì qualche tempo dopo, facendo naufragio vicino alla costa brasiliana. Entrambi, dopo anni passati all’estero, non hanno potuto rivedere il paese natale.
9. Molto spesso i critici lodarono il politico e il giornalista allo stesso tempo in cui rimproveravano aspramente il traduttore. Anche il poeta che aveva scritto qualche componimento molto apprezzato fu spesso lodato alla sua epoca e anche dopo. Uno dei giudizi più celebri e più aspri sulle traduzioni partì da un critico brasiliano che ebbe grande influenza negli studi letterari del paese, Sílvio Romero: «Per quanto riguarda le sue traduzioni di Virgilio e di Omero tentate dal poeta, la massima severità sarebbe ancora insufficiente a condannarle. Lì tutto è falso, artificiale, stravagante, impossibile. Sono delle vere mostruosità» (História da literatura brasileira, 4ª ed., Rio de Janeiro 1949, p. 35). E oltre: «In questo stile è sparita completamente la poesia del vecchio Omero. Le traduzioni di Odorico Mendes sono ingiustificabili; questo uomo, sebbene talentoso e colto, fu vittima di un sistema assurdo. Che ci serva di esempio per evitarlo» (p. 38). Quando si citano delle opere scritte originariamente in portoghese in questo saggio proporremo sempre la nostra traduzione in italiano.
10. La polemica sulla distinzione fra verso e prosa è riecheggiata da Filodemo (cfr. Introduzione di Janko a Philodemus On poems, Book one, Oxford, Oxford University Press 2000, p. 155ss.).
11. Cicerone ritorna al tema della somiglianza e della distinzione fra poeta e oratore nel De oratore, I, XVI, 70; III, VII, 27.
13. Rimettiamo all’edizione seguente dell’Eneide di Odorico Mendes, nelle cui note e commenti sono indicati molti prestiti da Camões: Vasconcellos, Paulo S. (ed.), Eneida Brasileira ou tradução poética da epopéia de Públio Virgílio Maro, Campinas, Editora da Unicamp-Fapesp, 2008.
14. Cicerone testimonia l’importanza dei suoni in poesia per gli Antichi: secondo lui, i poeti scelgono le parole soprattutto per la loro sonorità (exquisita ad sonum, Orator, 49, 163).
15. «Mi viene in mente che ho lodato moltissimo la purezza del suo portoghese, confessando che fra i contemporanei non conosco nessun altro, né in Portogallo, né in Brasile, che lo scriva meglio di lui» (lettera a Antônio Henriques Leal, in Gonçalves Dias, Poesia e Prosa Completa, Edizione di Alexei Bueno, Rio de Janeiro, Nova Aguilar 1998, p. 1130).
16. Odorico Mendes conia dei neologismi, ma spesso i neologismi che i critici gli censurarono erano parole prese da antichi scrittori portoghesi. Talvolta questi neologismi sono dei composti poetici che hanno anche la funzione di rendere più concisa la frase. Che questo fosse un ideale perseguito dal traduttore lo dimostra un dato curioso: dal canto VIII in poi, l’Eneide di Odorico presenta un numero minore di versi del numero dell’originale. In totale, il testo latino adottato da lui presenta 9.901 versi; la sua traduzione, nella seconda edizione, più concisa della prima, 9.946; quella del Caro e quella del Dryden 15.433 e 13.700 rispettivamente.
17. Cf. Sílvio Romero (Op. cit., p. 37): «La traduzione dell’Iliade è cinquanta volte peggiore: la clavi-argêntea espada [...] la olhi- cerúlea-crini-pulcra déia, la predadora Palas pulcrícoma», ecc. Quattordici anni dopo la morte del traduttore ecco un giudizio sull’Eneide Brasiliana che mostra come questo aspetto della traduzione di Odorico non sia stato compreso: «È così frequente l’uso di latinismi che diventa un abuso intollerabile» (Correa, Frederico José, Um livro de crítica, Maranhão, Typ. do Frias 1878, p. 50).
18. Dal saggio Miseria y esplendor de la traducción (Miseria e splendore della traduzione), del 1937, che citiamo nella traduzione italiana di Amparo Loazano Raniero e Claudia Rocco, in Nergaard, Siri (a cura di), La teoria della traduzione nella storia, Milano, Bompiani 1993, p. 205. Un’opinione del tutto diversa da quella di Ortega y Gasset si vede in Silvio Romero (v. nota precedente): «Una buona traduzione richiede soprattutto due cose, fedeltà e una naturalezza tale che il lettore si convinca di leggere un’opera originale invece di una versione» (ibidem, p. 54). Accettare come unica forma ‘corretta’ quella che evita qualsiasi impressione di stranezza davanti al nuovo testo porta questo critico a rigettare in blocco le traduzioni di Odorico. Noi crediamo che si debba sempre sostenere che non c’è un modello ideale di traduzione, atto a riprodurre l’essenza dell’originale. Assumere che ogni traduzione crea un nuovo testo in un altro sistema linguistico ci fa vedere l’illusione di chi pensa di aver trovato la traduzione ‘giusta’ – l’argomento è stato già molto discusso, ma i ‘laici’ hanno ancora spesso quella immagine della traduzione matematicamente corrispondente all’originale. Goethe punta sul fatto che ci siano vari tipi di traduzioni tutti validi (ma si noti l’ironia di fronte a un tipo specifico di traduzione): «Per la moltitudine, sulla quale occorre agire, una traduzione fluente è sempre la migliore. Queste traduzioni critiche, che rivaleggiano con l’originale servono soltanto per intrattenere i sapienti fra di loro» (Memórias: Poesia e Verdade, Porto Alegre, Globo 1971, volume 2, p. 381).
19. Da tradução como criação e como crítica in: Campos, Haroldo de, Metalinguagem & outras metas, 4a ed., São Paulo 1992, p. 34. Certo non è una tesi nuova, ma il Campos ha il gran merito di aver divulgato in Brasile delle idee che erano in quel contesto, alla sua epoca, nuove. Soprattutto ha messo in pratica (come suo fratello Augusto de Campos) le sue idee traducendo un numero esteso di testi poetici in lingue diverse (latino, greco, ebraico, giaponese, inglese, francese, russo ecc.); in questo intenso lavoro ha privilegiato quei testi più difficili, come qualche brano del Finnegans Wake. Per quanto riguarda i classici dell’Antichità ha tradotto fra gli altri qualche carme di Saffo e di Catullo, e tutta l’Iliade. Bisogna dire che non sempre la teoria e la pratica dei fratelli ricevettero un’accoglienza favorevole in ambito universitario: all’inizio tra i classicisti le reazioni contrarie non furono poche.
20. Come dice Jakobson: «Ma in che cosa si manifesta la poeticità? – Nel fatto che la parola è sentita come parola e non come semplice sostituto dell’oggetto nominato né come scoppio d’emozione. E ancora nel fatto che le parole e la loro sintassi, il loro significato, la loro forma esterna ed interna, non sono un indifferente rimando alla realtà, ma acquistano peso e valore propri» (R. Jakobson, Poetica e poesia. Questioni di teoria e analisi testuali, trad. di Renata Buzzo Margari et alii, Torino, Einaudi 1985, p. 53).
21. Gli esempi che qui proponiamo sono tutti tratti dalla traduzione di Virgilio alla quale da tempo stiamo lavorando, coordinando un gruppo di ricerca che si dedica alla preparazione di edizioni annotate e commentate del Virgilio di Odorico. Per ulteriori informazioni, si veda lo spazio dedicato al gruppo nel sito www.iel.unicamp.br.
22. Alcune testemonianze antiche: Ne spondeus quidem funditus est repudiandus, etsi, quod est e longis duabus, hebetior uidetur et tardior; habet tamen stabilem quendam et non expertem dignitatis gradum (Cicero, Orator, 64). Secondo Cicerone, Eforo prediligeva il peone ed il dattilo a causa delle brevi di questi piedi (tre o due); impiegandoli, grazie alla brevità e velocità delle sillabe, le parole fluivano in modo più rapido (breuitate et celeritate syllabarum labi putat uerba procliuius); invece, Eforo evitava lo spondeo, che rendeva il discorso troppo lento (nimis tardam orationem), e il tribraco, che lo avrebbe reso troppo veloce (nimis incitatam – Orator, 57, 192). Il ritmo fluisce più velocemente grazie alla brevità dei piedi e più lentamente grazie alla loro lunghezza (Fluit omnino numerus a primo tum incitatius breuitate pedum, tum proceritate tardius – Orator, LXXIII, 212). Secondo Quintiliano (Inst. Or., IX, 4, 83), se la frase è ricca di sillabe lunghe, il discorso diventa «più grave» (grauiorem faciunt orationem); se prevalgono le brevi, esso diventa «celere ed agile» (celerem ac mobilem). «La successione di lunghe ha maggiore peso e autorità, come ho detto; la successione di brevi maggior rapidità» (Plurimum igitur auctoritatis, ut dixi, et ponderis habent longae, celeritatis breves) (IX, 4, 91).
23. I testi virgiliani citati in questo articolo sono riprodotti come si leggono nell’edizione di Mynors: P. Vergili Maronis Opera, Oxonii, E Typographeo Clarendoniano 1990.
24. Mi sembra che talora i latinisti non prestino la dovuta attenzione al fatto che i testi poetici (nel senso, qui, di letterari) presentano un ordine delle parole che sarebbe considerato inconsueto nel linguaggio quotidiano. Sulla transgressio uerborum, si veda la Rhetorica ad Herennium, IV, 32, 44. L’esistenza di una sensibilità per l’ordine naturale delle parole si può ricavare da Seneca Ep. ad Lucilium 100, 5, che critica un modo di ordinare le parole contra naturam suam posita et inuersa. La definizione stessa di transgressio data dalla Rhetorica – Transgressio est quae uerborum perturbat ordinem peruersione aut transiectione – lo attesta bene: se l’iperbato perturbat l’ordine delle parole, si sentiva che c’era nel linguaggio ordinario un ordine che la linguistica chiamerebbe ‘non marcato’. Quintiliano offre come esempio di transgressio uerborum la frase del Pro Cluentio di Cicerone: «Animaduerti, iudices, omnem accusatoris orationem in duas diuisam esse partes» (Inst. Or., VIII, 6, 65). E aggiunge «‘in duas partes diuisam esse’ rectum erat, sed durum et incomptum» (ibidem). Chi lavora com i testi classici sa bene che questo è un esempio poco appariscente di fronte ai complessi disegni sintattici che troviamo in prosa come in poesia. Odorico Mendes sta attento a questi fenomeni: si ricavano dalle sue traduzioni – e da qualche nota – i tentativi di riprodurre disposizioni sintattiche che sembrano impossibili da tradurre.
25. Come dice Coleman: «The interweaving word order of the so called golden live ... reflects the complex visual pattern» (Coleman, Wendell (ed.), Vergil Eclogues, Cambridge 1994, p. 102).
26. Per esempio, Odorico non è ‘fedele’ allo stile formulare dell’epica. Per lui, le ripetizioni che si trovavano nelle epopee se tradotte alla lettera sarebbero ineleganti e perciò un tradimento della poesia dell’originale. Odorico osserva anche che talvolta delle presunte ripetizioni non lo sono propriamente in latino o greco, poichè in queste lingue la desinenza del caso cambia. Tradurre, diciamo, fluctus, fluctibus, ecc. sempre con ‘onda’ o simili nello stesso brano non sarebbe essere fedele nemmeno alla lettera del testo. È molto illustrativa la traduzione di un brano della tempesta nel primo libro dell’Eneide (vv.106-120, compresi i quattro versi che precederebbero arma uirumque; Odorico li considera autentici e li traduce): la parola fluctus qui si legge cinque volte, con variazione di caso, ma il traduttore non ripete mai una parola per tradurla, cercando la uarietas e sorprendendoci con la ricchezza del suo lessico (chi si immaginerebbe che ci fossero tanti sinonimi di ‘onda’ in portoghese?). Per il dettaglio, si veda Vasconcellos, Paulo Sérgio de (ed.), op. cit., p. 59. Infine: c’è in Odorico un impegno di natura filologica, come si vede dalle sue note erudite di commento ai poemi, ma quando gli interessi del filologo si confrontano con quelli del poeta, questi ultimi hanno in genere il sopravvento.
¬ top of page






