
« indietro
EUGENIO DE SIGNORIBUS, Trinità dell’esodo, Milano, Garzanti, 2011, pp. 144, € 16,50.
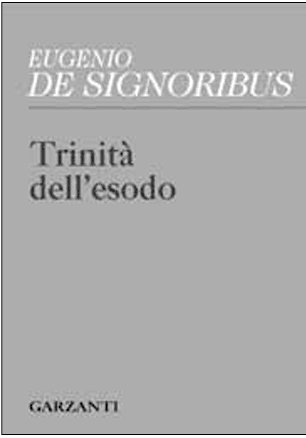
Che forma può assumere una Trinità? Quali sono le tre possibili facce, le tre di mensioni dell’unità distinta e concentrica? Come si esprime il luogo del vuoto su cui girano, unisoni, i tre cerchi? E qual è la forma, quali le facce e l’espressione di tutto ciò all’altezza del nostro presente? Domande altissime, quelle che si pone nell’ultimo suo percorso poetico Eugenio De Signoribus. O meglio, domande al tissime quelle che il poeta ci costringe a porci. Trinità dell’esodo, questo il titolo del percorso. Ma un titolo che pone un assurdo, giacché l’esodo, quello del Vecchio Testamento, accadde fuori dello schema trinitario, al tempo in cui c’era solo il Padre, vendicativo, violento, sovrano. E assurdo anche perché qui la trinità si pone come paradigma dell’esser fuori, quando al contrario – tanto storicamente quanto ‘millenariamente’ – essa significa il ritorno verso il dentro, l’affermazione del ritorno all’Alleanza, sancito dal Sacrificio del Figlio e dalla Discesa dello Spirito Santo. Facciamo allora un passo più dentro al testo. Prendiamo l’indice, dove troviamo tre sezioni (delicatamente orchestrate tra testi in corsivo e testi in tondo, bilanciate tra sottodivisioni ed epigrafi), le quali sono intitolate, rispettivamente, all’Evo paterno, alla Cruna filiale e alla Rua dello spirito. Ecco, mai nella storia poetica degli ultimi anni si è avuta occasione in cui il meccanismo dei titoli fosse così forte, esplicito e, infine, efficace (fatto salvo il caso delle macchine a orologeria di Gabriele Frasca, che però vanno, com’è chiaro, in tutt’altra direzione). Provo, in forma di recensione, a offrire un contributo alla comprensione di questa sequenza. L’evo, il tempo, il determinarsi nel tempo, e anzi lo stesso determinarsi del tempo (l’essere nel tempo: che è come l’essere-per la morte di Heidegger) è fatto del padre. Si è sempre in un evo, in un’epoca segnata dal padre, il quale segnò per ciascun figlio, dunque per ognuno, il fatto di (av)venire nel tempo. Di contro, il figlio è sempre nel luogo della cruna, lì dove si misurerà il suo valore, ma soprattutto lì dove dovrà piegarsi, inginocchiarsi innanzi alla sua croce, al suo momento epocale, al proprio essere stato chiamato a determinarsi e darsi un nome. Questa verità del figlio può accadere in molti modi, per esempio scegliendo di essere padre a sua volta. Ma centrale resta il fatto che egli debba giungere a convertirsi, cioè, per dirla col lessico di tutti giorni, a ‘svoltare’, che vuol dire semplicemente: a interpretare come propria la strada su cui cammina. Fatti i primi due passi tra tesi e antitesi, tra poli opposti, sia pure dinamici, irrompe nella terza sessione lo spirito, la «verità che circola». Forse, per capire questo passaggio, varrebbe la pena, per comprendere questa dimensione, di tornare a quello spiritus phantasticus che, incrociando la metafisica stoica e il pensiero di Plotino, giunse fino al Medio Evo di Cavalcanti e all’Umanesimo di Ficino; quello spiritus che è animatore materiale della cono scenza, transito fisico di immagini sotto forma di particelle, da cui si producono tanto la poesia quanto la gravidanza. Ma, in ogni caso, appare evidente che materia e ‘spirito’ sono qui collegate, com’è del resto necessario che sia. Lo illustra la nota d’autore che chiude il volume, lì dove De Signoribus spiega «Rua dello spirito: dal latino ruga, ‘crespa, grinza della pelle’ ma anche ‘via stretta’, così qui intesa». Dalla topografia urbana, semmai di Genova, città già cara al poeta marchigiano in altre sue raccolte, si passa all’evangelica ‘porta stretta’, attraverso la quale siamo rinviati nuovamente alla dimensione trinitaria. Salvo un’ulteriore torsione verso l’ebraismo, cui di nuovo ci costringe la continuazione della nota, lì dove si legge che «[i]l termine acquista una singolare suggestione con l’aggiunta del respiro dell’h, ruah, che, nell’ebraico, vale ‘spirito’, soffio dello spirito. Come spiritus: latino, cristiano». Ed ecco la ‘chiusura della trinità’ che questo libro, Trinità dell’esodo, ci propone. Dal padre al figlio allo spirito. Laddove non c’è alcuna santità in questione, ma una circolazione, un passaggio dall’uno all’altro ‘per opera e virtù di’ uno ‘spirito’, che non ha nulla a che vedere con l’idealizzazione dello ‘spirito santo’, ma che al contrario è insieme carne e soffio vitale: che è insomma sperma, generazione fisica – logos spermatikos, dicevano infatti gli stoici. Formulando queste ipotesi di interpretazione della strategia trinitaria di De Signoribus, non presumo affatto di ridurre il suo libro a una dimensione religiosa in senso confessionale. Al contrario, a mio avviso questa Trinità è senza alcun dubbio determinata in senso laico, addirittura in senso materialistico, e comunque in senso storico. Tra gli altri numerosi aspetti, stilistici e tematici, che lo confermano c’è del resto l’emersione – è il caso di dirlo, giacché di acqua si parla – anche in questo libro della figura del viandante, di colui che è in un «punto di svolta» definitivo (cfr. il testo a p. 90, a conferma peraltro di quanto si è affermato poco sopra). Stringendo insieme evidenza della storia attuale e orizzonte profondo della nostra cultura antica, Eugenio De Signoribus, dopo la Ronda dei conversi, ci offre con questo ultimo suo libro un nuovo percorso poetico che quasi potrebbe dirsi la rappresentazione di una ‘rotta dei dispersi’, un tracciato e una sconfitta di cui una voce, residua le, vorrebbe ancora testimoniare: «forse non ti riconosco, voce, / perché in te non rinasco // ma mi dibatto e commuovo / per il balbettio dei tuoi occhi // […] // e ti ascolto e ti accolgo / e verso te m’attiro // come una vocale / dentro una parola». Una vocale, lo spirito che transita prima che su di una consonante sia ribadito il mutismo (o si giochi, su una h, il transito di vocale in vocale). Basti ricordare, tra i tanti racconti mitologici sulla nascita del linguaggio, quello di Hegel: illuminati in pieno dal sole, gli animali urlavano le loro vocali, quando uno di loro all’improvviso serrò la bocca, producendo un suono così duro, così sofferente… Lì, su quel la pausa del fiato, quando lo spirito in terruppe la sua circolazione, a quel che pare, gli uomini, infine, si riconobbero, e si distinsero dentro quello spazio così pieno di sole.
(Giancarlo Alfano)
(Giancarlo Alfano)
¬ top of page







