
« indietro
RENATA MORRESI, Cuore comune, Ancona, Pequod, 2010, pp. 111, €12,00.
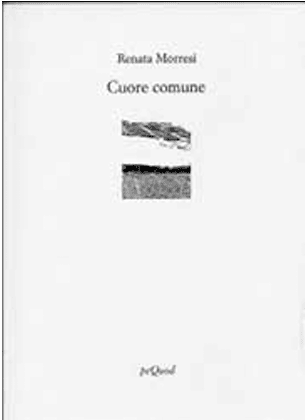
Esistono diversi tipi di libri d’esordio. Il tipo dell’esordio errato, o errante, e quello invece subito perfetto e insuperabile. Il tipo dell’esordio-assaggio (o addirittura saggio), e quello del preambolo dubbioso e drammatico. Ma esiste anche il libro dell’esordio maturo, che non suona esattamente come un esordio, anche se – tecnicamente – lo è. Tale è Cuore comune di Renata Morresi, pubblicato da Pequod, nel 2010. Come dimostra la sua struttura classica – sei sezioni, la seconda delle quali suddivisa in due parti –, traccia evidente di una complessità che trascende gli argumenta familiari delle poesie, questo libro è stato (osserva opportunamente Massimo Gezzi nella bandella di copertina) «a lungo meditato»: molti anni di lavoro e di ricerca (non solo poetica) si raccolgono intorno ai temi che sarebbe riduttivo definire ordinari, se non se ne sentisse da più parti la necessità di sottrarli alla pubblica esibizione massmediatica: casa, matrimonio, nascite, battesimi, problemi familiari, vita di coppia, amore, vacanze, affetti, ecc. Trattasi di temi privati – affetti che si perdono e si ritrovano, vite che si incrociano e si allontanano, coppie che si avvicinano e si separano – che la Morresi non propone nella generica accezione di un’esistenza grigia eprecaria, esposta a un labile minimalismo del quotidiano, tutt’altro, prova a distendere in un orizzonte gravido di un’«attesa di senso». La generazione cui appartiene la Morresi, del resto, lo autorizza, anzi ci incoraggia a credere che il destino della poesia consista ancora nella sua profonda «onestà» (quella che sarebbe piaciuta a Saba), estranea ma non ignara delle regole del Mercato. Il pregio maggiore di questa raccolta, dunque, potrebbe essere quello etico. Il lettore entra nel campo visivo dell’autrice, nel suo mondo, con un movimento veloce di flash, attratto da una luce che frammenta i testi, vibra sulle parole, sfoglia i versi (nella prima sezione Casa delle case), e alla fine ne esce come in un giardino che si apre su un paesaggio di scabrosa dolcezza (penso in particolare ad alcuni testi delle sezioni La terra distesa e Cuore comune), interrogandosi sull’apertura dello sguardo. Quello sguardo capace di «distrarre» i lettori, invitandoli a percorrere sentieri laterali, e a ritoccare i margini delle cose, la cornice della storia, insomma a sfumare i pensieri: «Ti penso, campagna, / mi arrivi nel sonno / protetta dal vetro dell’auto // lui guida cantando Graziani (‘vivo / in un paese che confonde’) / io ringrazio passeggera ogni albero che passa, / che resta, / mitemente assoluto / in lento dialogo / col resto» (p. 91); fino a centrare finalmente, in un movimento casuale di inquiete traiettorie visive, qualche lembo di verità: «Con lo sguardo vago in corridoio / passando dal riflesso delle foglie / al mormorio condominiale: / parcheggiare, portone, la sedia, / tapparelle, aperte e chiuse, / una figlia» (p. 99). Negli interstizi di questo sguardo si insinuano le riflessioni su una vita che perdura come qualcosa di già avvenuto, da sempre, e lo avvertiamo –mi viene da dire lo apprendiamo – nelle pagine più felici della raccolta come Forme uniche della continuità nello spazio, fra sentimenti che la poetessa evoca, addirittura cita in un universo discorsivo indifferente ai nostri dubbi, incurante (e non è esagerato avvertire una vena leopardiana nel paradigma dei modelli poetici della Morresi: dalla Dickinson a Adrienne Rich ad Amelia Rosselli) della nostra condizione: «‘La vita si occupa di ciò che fa / la vita’ […] Eppure mi pare che ripeterlo / di volta in volta cambi la giornata / in giallo di paglia e oro…» (p. 74). Fra la prima e le ultime due sezioni si snoda però un piccolo canzoniere di formazione che trascorre da un Album di foto all’altro, come in una sorta di tracciato visivo della memoria, onde approdare a un altrove che materializza sogni e bisogni della nostra società del benessere (ovvero della paura del malessere), e nello stesso tempo ci proietta in un tempo sospeso, in un non-tempo: «Dal promontorio al tramonto vediamo / sorgere la luna come un papavero / mite, selvaggio e logoro pensiero // non avere più niente che guardare il suo levare, alto, per un tempo / liberamente lungo, come il mare» (p. 51). La grazia della Morresi si vede sia nelle argute cronache dall’«antimondo» della vacanza, dall’«azienda della felicità», sia nelle surreali scenografie (soprattutto in quelle suggerite dalla vastità marina) che all’improvviso sembrano incendiare il gesto lirico di una parola (sia pure in una breve ma toccante cartolina, come in A un amico) evidentemente in grado di sottrarsi alla coazione ornamentale di un non-luogo quale il villaggio turistico. Di qui il desiderio di un ritorno alla vita, alle svariate e capricciose figure che la compongono come un quadro evanescente di una moltitudine di singoli, di solitudini di massa di cui la poesia non smette di parlarci: «Siamo tutti al completo, stretti / in questi condomini, / siamo tutti informati subito / dell’accaduto, dei futuri possibili // occupati a mantenerci singoli, / staccati, come elementi folli / di non decadere, di tirare / un colpo alla natura // che la cosa difficile – / intera, durare» (p. 105).
(Salvatore Ritrovato)
(Salvatore Ritrovato)
¬ top of page








